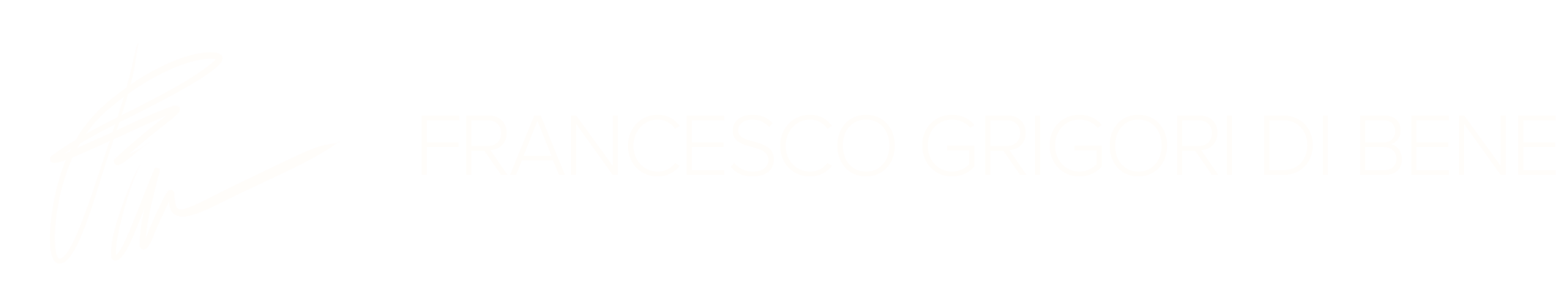La pastorizia è una delle forme più antiche di relazione tra l’uomo, la terra e gli animali. È un sapere incarnato, tramandato con la voce, con le mani, con i passi. Oggi, in un mondo che corre verso l’omologazione tecnologica e la produzione di massa, la vita dei pastori resiste come un corpo estraneo dentro un sistema che misura tutto in efficienza, profitto e velocità. Ma questa relazione millenaria è sul punto di spegnersi — non solo come economia, ma come linguaggio del corpo e dell’anima
I pastori del mondo — dai monti della Sardegna alle steppe del Caucaso, dalle valli d’Abruzzo alle distese della Patagonia, fino agli altopiani dell’Asia Centrale — condividono gesti, suoni, paesaggi interiori. Cantano in polifonia, come se il dialogo tra voci fosse l’eco di un’armonia universale; si orientano al buio guardando le stelle; vestono abiti, per quanto moderni siano, che portano ancora addosso l’odore dell’erba, della lana, del latte.
I pastori del mondo — dai monti della Sardegna alle steppe del Caucaso, dalle valli d’Abruzzo alle distese della Patagonia, fino agli altopiani dell’Asia Centrale — condividono gesti, suoni, paesaggi interiori. Cantano in polifonia, come se il dialogo tra voci fosse l’eco di un’armonia universale; si orientano al buio guardando le stelle; vestono abiti, per quanto moderni siano, che portano ancora addosso l’odore dell’erba, della lana, del latte.
Di Sangue, Latte e Cielo è un progetto fotografico, multimediale e narrativo che attraversa questi luoghi e queste vite, per raccontare la somiglianza nascosta tra culture lontane e per indagare ciò che sopravvive, e ciò che si perde, del nostro legame più antico: quello con la natura e con la necessità.
È un viaggio visivo e sonoro tra pastori che resistono, che ancora si sporcano le mani e che ogni giorno rinnovano — consapevolmente o no — un rito universale di appartenenza.
È un viaggio visivo e sonoro tra pastori che resistono, che ancora si sporcano le mani e che ogni giorno rinnovano — consapevolmente o no — un rito universale di appartenenza.
Francesca Leli, Campotosto (Italia)
Il progetto
Da sempre i pastori percorrono paesaggi di tutto il mondo, guidando le greggi attraverso montagne, deserti e steppe. Nonostante le enormi differenze di geografia, lingua e religione, le comunità pastorali condividono tradizioni, gesti e ritmi sorprendentemente
simili. Di sangue, latte e cielo è un progetto fotografico e multimediale che vuole catturare queste connessioni profonde, esplorando canti, abiti, notti e cibo per svelare lo spirito universale della pastorizia.
simili. Di sangue, latte e cielo è un progetto fotografico e multimediale che vuole catturare queste connessioni profonde, esplorando canti, abiti, notti e cibo per svelare lo spirito universale della pastorizia.



L’orgoglio e la vergogna
Convincere Antonio a parlare e a farsi fotografare può essere fatto solo tramite un contatto comune. La prima domanda che ci fa al telefono quando gli parliamo del progetto è “vuole fotografare i pastori come sono ora o la versione per turisti, vestiti con abiti che non si usano più da 50 anni?”.
Capisco che è serio da questa semplice domanda, che sembra ma non è un test, perchè dietro il punto interrogativo si nasconde un'affermazione ben precisa. “Non siamo quello che tutti vorrebbero che fossimo”. Ed ha ragione, perché l’attuale narrazione su
quello che è uno dei mestieri più antichi del mondo, e che tuttora rimane fondamentale per tutti, è in costante beccheggiare tra il folk e il disprezzo, un disprezzo culturale che, almeno in italia, va avanti da sempre e che si mischia all’immaginario cittadino del mestiere antico e tanto affascinante se discusso nel salotto della villa, mai esperito con le scarpe sporche di merda e paglia
semi-masticata della realtà. E il pastore è la sublimazione di questo disprezzo, è orgoglioso ogni singolo giorno che inizia prima dell’alba, che sia tra il ghiaccio dell’inverno o sotto il diluvio ed è altrettanto sicuro che nessuno - dall’esterno - lo capirà. E Antonio è sardo, figlio, nipote e bisnipote di pastori che nelle generazioni, iniziando nella miseria della vita pastorale di montagna, sono riusciti, lottando contro potenti possidenti terrieri, ladri di bestiame, siccità, alluvione e progresso economico e tecnologico, ad arrivare alle “ricche” pianure del Logudoro. Un viaggio duro, spietato, intriso della vergogna che un ragazzo che fa il “pecoraro”, termine dispregiativo che per decenni è stato usato per definire rozzezza, ignoranza, isolamento, ha provato ogni volta che interagiva col mondo “educato”, cittadino, civile. Eppure Bachisio Bandinu, antropologo di Bitti, che per una vita intera ha studiato la civiltà pastorale sarda, definisce questa civiltà urbanizzata come sterile e povera di pensiero, quel pensiero che invece si forma nell’università dell’ovile e che si costruisce nel silenzio della campagna, dove la mente osserva il mondo e ne elabora le dinamiche nelle lunghe ore al freddo pungente o al caldo insopportabile.
quello che è uno dei mestieri più antichi del mondo, e che tuttora rimane fondamentale per tutti, è in costante beccheggiare tra il folk e il disprezzo, un disprezzo culturale che, almeno in italia, va avanti da sempre e che si mischia all’immaginario cittadino del mestiere antico e tanto affascinante se discusso nel salotto della villa, mai esperito con le scarpe sporche di merda e paglia
semi-masticata della realtà. E il pastore è la sublimazione di questo disprezzo, è orgoglioso ogni singolo giorno che inizia prima dell’alba, che sia tra il ghiaccio dell’inverno o sotto il diluvio ed è altrettanto sicuro che nessuno - dall’esterno - lo capirà. E Antonio è sardo, figlio, nipote e bisnipote di pastori che nelle generazioni, iniziando nella miseria della vita pastorale di montagna, sono riusciti, lottando contro potenti possidenti terrieri, ladri di bestiame, siccità, alluvione e progresso economico e tecnologico, ad arrivare alle “ricche” pianure del Logudoro. Un viaggio duro, spietato, intriso della vergogna che un ragazzo che fa il “pecoraro”, termine dispregiativo che per decenni è stato usato per definire rozzezza, ignoranza, isolamento, ha provato ogni volta che interagiva col mondo “educato”, cittadino, civile. Eppure Bachisio Bandinu, antropologo di Bitti, che per una vita intera ha studiato la civiltà pastorale sarda, definisce questa civiltà urbanizzata come sterile e povera di pensiero, quel pensiero che invece si forma nell’università dell’ovile e che si costruisce nel silenzio della campagna, dove la mente osserva il mondo e ne elabora le dinamiche nelle lunghe ore al freddo pungente o al caldo insopportabile.

La famiglia Denule, Giovanna, Salvatore, Salvatore, Antonio. Oschiri (Sardegna)

Salvatore Denule (94 anni)
"Essere pastori è un modo di vivere. Non si impara la professione. Io, bambino di otto, dieci anni, vengo svegliato alle 04:00 per stare vicino alla mandra dove mio padre sta mungendo il gregge.
Ma perché svegliare un bambino di dieci anni alle 04:00 per farlo stare in piedi a guardare, perchè non farlo entrare per provare?
Perché non esiste la scuola nel senso del provare e riprovare, tipica dell'insegnamento ufficiale. Il bambino deve stare lì, a mungere saprà mungere non è quello il problema, perchè il corpo deve abituarsi a resistere al freddo invernale e al caldo estivo con lo stesso abito, con lo stesso abito! E’ il corpo che deve costruirsi."
Bachisio Bandinu
Ma perché svegliare un bambino di dieci anni alle 04:00 per farlo stare in piedi a guardare, perchè non farlo entrare per provare?
Perché non esiste la scuola nel senso del provare e riprovare, tipica dell'insegnamento ufficiale. Il bambino deve stare lì, a mungere saprà mungere non è quello il problema, perchè il corpo deve abituarsi a resistere al freddo invernale e al caldo estivo con lo stesso abito, con lo stesso abito! E’ il corpo che deve costruirsi."
Bachisio Bandinu


Silvia Meloni, Berchidda (Italia)
Il peso della morte
Silvia ha un sorriso aperto, sia quando ci accoglie, sia quando ci presenta le sue pecore, per nome. Ogni agnello è figlio di un montone e di una fattrice che lei ha cresciuto, che hanno un carattere, un’identità, una storia. Quell’agnello cresciuto con amore e dedizione finirà al macello, ci racconta, a volte ha dovuto sgozzarne qualcuno lei stessa a causa di una gastroenterite, ad esempio, che lo aveva condannato a morte. Ed è in quel momento che il sorriso si spezza, gli occhi si inumidiscono e il racconto si fa difficile, pesante, un racconto che parla di senso di responsabilità, di amore e di rispetto per la sua professione, per il suo ruolo nel mondo, per gli animali che alleva e a cui dà un nome. La responsabilità che in troppi, nell’era del consumismo, dell’allevamento intensivo e industrializzato, hanno dimenticato. Acquistare la carne confezionata in un contenitore di plastica, pronta al consumo, ci ha fatto dimenticare che qualcuno si deve far carico del dolore di uccidere, e non esiste meccanismo di difesa per questo se non la capacità di portarne il peso.
Oggi, ancora più di ieri, il ruolo di allevatore è paragonato a quello del carnefice, anestetizzato nei confronti della morte solo grazie alla perdita dell’empatia, questo non fa altro che aumentare il pregiudizio nei confronti di un mestiere necessario alla sussistenza dell’umanità. E la conseguenza è la diffidenza dei pastori, ancor più che in passato, verso il mondo esterno, che mentre ne sfrutta il lavoro, li giudica. Le parole di Silvia, la fierezza di cui sono intrise, hanno il suono battagliero di chi si sporca le mani e, nonostante tutto, non perde la sua empatia, la sua capacità di piangere. Di chi, giorno dopo giorno, fa il suo dovere.
Oggi, ancora più di ieri, il ruolo di allevatore è paragonato a quello del carnefice, anestetizzato nei confronti della morte solo grazie alla perdita dell’empatia, questo non fa altro che aumentare il pregiudizio nei confronti di un mestiere necessario alla sussistenza dell’umanità. E la conseguenza è la diffidenza dei pastori, ancor più che in passato, verso il mondo esterno, che mentre ne sfrutta il lavoro, li giudica. Le parole di Silvia, la fierezza di cui sono intrise, hanno il suono battagliero di chi si sporca le mani e, nonostante tutto, non perde la sua empatia, la sua capacità di piangere. Di chi, giorno dopo giorno, fa il suo dovere.


Steven Okono, Oschiri (Italia)



Fame di terra
Fino agli anni ’90, sul finire di settembre, Campotosto era un caos di greggi che venivano caricate sui camion per la transumanza verso le pianure dell‘Agro Romano, ormai non era più possibile fare la transumanza a piedi, come fino agli anni ’60. Ora invece non c’è più caos, solo il silenzio dei paesi abbandonati, e del vento freddo che inizia a spingere da nord, come ogni inizio primavera. Non si muovono più le 50.000 pecore verso i pascoli a valle, a passare l’inverno. Le porte dei pochi edifici non ancora abbandonati, sono sbarrate da metà agosto, dopo che i villeggianti sono tornati a Roma, figli e nipoti di pastori, sconfitti dal benessere, dal mercato e da un mondo che li ha dimenticati, messi da parte in un angolino dedicato al folklore, da ricordare solo in vacanza, quando si va per paesi a stupirsi della bella vita di campagna. Quando chiedo a Ercole, ormai ex-pastore che mi parla di una cultura che non c’è più: “Quale sarebbe una soluzione?”, mi risponde: “Dovrebbe sparire lo Stato – ci dovrebbe essere
l’anarchia”. E mi torna in mente il codice barbaricino sardo, che si sviluppa nella cultura pastorale, con regole e usi spesso in
contrapposizione con lo Stato “civile”, perché lo Stato è lo strumento del controllo, del mercato, del profitto, è benessere
che si propaga come un virus e uccide. E come quei pastori che per millenni hanno colonizzato le terre povere, i pascoli aridi, le
montagne scoscese, costantemente alla ricerca di nuove terre verdi e temperate, e che una volta trovate sono stati da esse
domati, civilizzati, decretandone la trasformazione e quindi la condanna, così lo stato continua ad addomesticare i pastori.
Perchè i pastori sono considerati un disturbo, dai turisti della montagna, dalle associazioni animaliste, dalle grandi aziende
alimentari, e saranno combattuti finchè anche l’ultimo non avrà lasciato quelle terre all’abbandono.
l’anarchia”. E mi torna in mente il codice barbaricino sardo, che si sviluppa nella cultura pastorale, con regole e usi spesso in
contrapposizione con lo Stato “civile”, perché lo Stato è lo strumento del controllo, del mercato, del profitto, è benessere
che si propaga come un virus e uccide. E come quei pastori che per millenni hanno colonizzato le terre povere, i pascoli aridi, le
montagne scoscese, costantemente alla ricerca di nuove terre verdi e temperate, e che una volta trovate sono stati da esse
domati, civilizzati, decretandone la trasformazione e quindi la condanna, così lo stato continua ad addomesticare i pastori.
Perchè i pastori sono considerati un disturbo, dai turisti della montagna, dalle associazioni animaliste, dalle grandi aziende
alimentari, e saranno combattuti finchè anche l’ultimo non avrà lasciato quelle terre all’abbandono.
Ercole Di Girolami, Campotosto (Italia)

Claudio, Cesacastina (Italia)

Nunzio Marcelli, Anversa degli Abruzzi (Italia)
Pastori, nemici.